«Recinti urbani. Roma e i luoghi dell’abitare», è il titolo del libro di Carlo Cellamare, Roberto De Angelis, Massimo Ilardi ed Enzo Scandurra edito da manifestolibri.
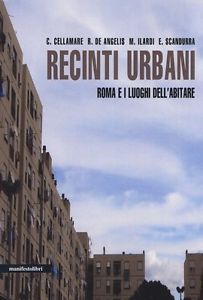
Due urbanisti, un antropologo e un sociologo descrivono le loro decennali ricerche sulle periferie romane attingendo non solo alle esperienze disciplinari ma anche ai ricordi del loro vissuto. Ne viene fuori il racconto di un lungo viaggio che attraversa Roma dalla Serpentara al Mandrione, dalla Borgata Finocchio all’Idroscalo.
Parafrasando, anzi citando letteralmente alcune righe che anticipano i contenuti di un libro di qualche anno fa a cura di vari autori [1], potremmo dire che questo, primo di una collana che ha per tema il territorio, nasce da un sentimento semplice: dal vuoto che lascia il troppo pieno. Perché di territorio si parla dovunque e ne parlano tutti. Se ne parla nei bar e nelle piazze, dove si incontrano le persone, se ne straparla quando avviene una catastrofe “naturale” come in questi giorni in Sardegna.
Ne parlano gli storici, gli ambientalisti sempre con riferimento alle sue non innocenti trasformazioni, ne parlano gli etologi, gli economisti, i sociologi, gli antropologi e di esso ne parlano con frequenza quotidiana i giornali, le televisioni e così via.
Questo continuo citare questa parola – territorio – da parte di tutti e dovunque fa perdere ad essa il suo significato, diventa un modo convenzionale di indicare qualcosa che apparentemente tutti presumono di conoscere ma che è invece assai difficile definire. Un po’ come la parola “tempo” della quale Sant’Agostino soleva dire: io so cos’è il tempo ma se qualcuno mi chiede di spiegare questa parola ho qualche difficoltà a farlo.
Ebbene gli autori di questo libro hanno tentato di tracciare un percorso per tutti quelli che scriveranno su questa collana. Non tanto cercando di dare una definizione univoca di territorio – cosa che avrebbe comportato un’adesione dogmatica a un pensiero ancora una volta unico, e dio ce ne guardi bene dal farlo – ma pescando nel profondo autentico del proprio vissuto professionale o, anche, della propria vita. Certamente chi legge non troverà risposta alla semplice domanda: cos’è territorio? Anzi non troverà senz’altro alcuna risposta tanto più nei termini della disciplina da lui frequentata e coltivata. In un certo senso più che dare risposte abbiamo invece, quasi al contrario, complessificato il tema affrontato.
Piuttosto che limitarci ad aggiungere il tema della sua salvaguardia e tutela al coro delle tante voci, piuttosto che aggiungere la nostra disperazione a quella dei tanti che ne constatano il degrado progressivo e piuttosto ancora di insabbiarci su una disquisizione tassonomica, abbiamo scelto la strada di raccontare dove e come abbiamo incontrato, nel nostro percorso, questa parola e come abbiamo finito con l’interessarsi ad essa.
Per comprendere quanto il territorio sia fondamentale nello sviluppo delle comunità e perfino degli stessi singoli individui, citiamo brevemente due episodi tratti dai libri di Ernesto De Martino [2]. Il primo riguarda gli usi attraverso i quali gli aborigeni Achilpa esprimevano il loro rapporto con esso [3]. Popolazione nomade, ogni volta che gli Achilpa si fermavano in un luogo piantavano un palo (il Kiwawa) per segnare simbolicamente il centro del mondo, marcando le loro coordinate, plasmando lo spazio. Il secondo racconto è quello del pastore calabrese e il campanile di Marcellinara [4].
Racconta De Martino che un giorno, in un paese della Basilicata, offrì un passaggio in auto a un vecchio pastore calabrese che si stava recando fuori dal paese. Il famoso antropologo notò ad un certo punto che questo pastore, man mano che l’auto si allontanava dal paese, volgeva la testa all’indietro con inquietudine crescente. Ad essa De Martino diede il nome di “angoscia territoriale” perché qualche tempo dopo scoprì che l’ansia crescente provocata dal viaggio in auto era dovuta alla sparizione dalla sua vista del campanile di Marcellinara, che, da sempre, per il contadino era stato il punto di riferimento di ogni suo spostamento a piedi. Anche oggi, seppure ad una scala diversa e con modalità diverse, si usano termini come de-territorializzazione o sradicamento per indicare quella stessa sensazione di trovarsi fuori dal proprio territorio in una regione aperta senza più riferimenti.
Coglieva De Martino, in quella sua riflessione di studioso di antropologia, senza alcuna concessione alla retorica, un sentimento profondamente radicato nella psiche di ogni persona: quella di appartenere a qualcosa, di avere un legame con un luogo, una radice che costituisce un riferimento simbolico ineliminabile. Anche nel caso degli Achilpa, la perdita del palo o la sua rottura provoca la sensazione di spaesamento, produce il sentimento del non sentirsi a casa propria. “L’angoscia”, dunque, “apre il rischio di non poterci essere in nessun mondo culturale possibile e quindi di non esserci affatto, di perdersi nella “isolata” intimità privata e incomunicabile, di spaesarsi rispetto ad ogni possibile “paese”. Questa storia ci è stata raccontata in tanti modi dalla letteratura, dalla poesia, dalla narrativa.
Il territorio è sempre raccontato. Ad ogni racconto fatto da una generazione di uomini si aggiunge quello della generazione successiva così che esso – il territorio – entra a far parte delle storie di vita, storie di conflitti spietati, di lotte ancora più cruente, di legami, di memorie, di amori, oppure di regioni scomparse per effetto dei violenti cambiamenti dell’economia o per l’avidità dei vincitori. Il metodo scientifico moderno ci dice come cercare di conoscere e di rappresentare il territorio nella sua apparizione più reale possibile.
Questo metodo è ampiamente diffuso nel mondo accademico ma spesso ha il difetto di lasciarci indifferenti in quanto contiene una buona dose di autoreferenzialità e riduce la complessità di questo termine a una piatta razionalità portatrice dell’unica verità. Non che tale metodo non abbia la sua efficacia nel campo della ricerca consentendo anche passi avanti nel campo della conoscenza. Il problema è che esso rimuove i legami che ciascuno di noi ha col proprio territorio (quale che sia o quali che siano). In tal senso la spesso abusata frase: la mappa non è il territorio, sta a significare che ciascuno di noi produce una propria rappresentazione, un proprio schema interpretativo che si aggiunge (confrontandosi e scontrandosi) a quelli prodotti da altri uomini, così che non è data una rappresentazione univoca dello stesso territorio.
Il problema della sua definizione, della definizione della parola territorio, può essere aggirato se partiamo dal presupposto che esso è il luogo in cui si co-abita, intesa questa come forma dello stare insieme tra esseri viventi e tra questi e la natura. Ne consegue, come afferma il geografo Dematteis, la responsabilità dell’essere-in-comune che è al tempo stesso ecologico, culturale, sociale, economico, politico. Questa coabitazione non è quasi mai pacifica, così che il territorio finisce per essere un luogo di conflitti permanenti conseguenti al non riconoscimento dell’altro o al non riconoscimento del non umano, o del non vivente. Conflitti conseguenti, ancora, ai diversi valori di cui sono portatori gruppi diversi presenti su di esso, e così via. In ogni caso non esiste un territorio fuori dalla storia degli uomini che lo abitano o che lo raccontano. In tal senso il territorio è sempre una costruzione culturale fatta anche delle inevitabili cariche emotive ed affettive che lo legano ai suoi narratori.
In un certo senso, questo libro parla di tre distinti “territori”, non perché gli autori si riferiscono a luoghi diversi, quanto piuttosto perché aprono a mondi diversi, a interpretazioni diverse, a modi diversi di vedere ad esso. Il territorio descritto da De Angelis è quello di una periferia storica di Roma: San Basilio, situato su una delle consolari romane (la Tiburtina) dove più visibile è la mutazione da promessa dello sviluppo fordista (la famosa Tiburtina Valley per parafrasare il ben più noto distretto industriale di San Francisco) a paesaggio postmoderno costellato a tratti da manufatti che celebrano la società dei consumi. San Basilio è una pezzo importante della storia di Roma e non soltanto delle sue periferie.
Nato come costola espulsa dal centro di Roma ai tempi del fascismo, ha rappresentato nei primi anni Cinquanta uno dei primi insediamenti di edilizia pubblica. De Angelis ce ne descrive la trasformazione feroce attraverso il racconto di brani di vita di alcuni suoi abitanti. Oggi “La ex borgata fascista fatta di paglia compressa è un quartiere di case di edilizia popolare pubblica urbanisticamente più che decoroso, una “città-giardino” se si considera il rapporto verde-costruito. Un quartiere-pensionato di abitanti sempre più anziani e in condizione di deprivazione […]”. Ma la condizione dei suoi abitanti è drammatica, per i giovani c’è un avvenire senza speranza fatto di traffici illeciti di droga che costituiscono una fonte di reddito diffusa e generalizzata. Anche questo territorio disperato è Roma, la sua storia, il suo lato d’ombra, una delle sue molteplici maschere fuori dalla scena principale.
Anche Carlo Cellamare sceglie come tema alcune parti di Roma. La sua descrizione riguarda un “territorio” fatto di episodi di autogestione, autorganizzazione da parte di comitati di lotta che, un po’ dovunque, cercano di farsi carico dei disagi della periferia: da Serpentara al Mandrione, da Tor Fiscale alla borgata Finocchio, alla Borghesiana. Territori spesso lontani dal centro della città e che vivono una condizione subalterna. Qualche volta si sviluppano in essi forme interessanti di solidarietà come la cura di un orto, di un piccolo parco, di un qualche elemento simbolico. Borghesiana rappresenta una di queste memorie della città, quella legata all’abusivismo: “è la storia difficile della ricerca della casa, del raggiungimento almeno delle condizioni minime dell’abitare; è la storia profonda di una città che si è dovuta “autocostruire”, che rimane sempre inadeguata, sottomisura, mai pienamente di qualità, sebbene sempre amata […]”.
Il “territorio” raccontato da Massimo Ilardi (Trastevere) è assai diverso da quello delle guide turistiche del centro di Roma. Anni fa, ci dice Ilardi, esso costituiva una delle periferie di Roma, situato “al di là” del fiume; un regno autonomo con “leggi speciali” che ne facevano un luogo malfamato e pericoloso per quelli che vi transitavano. Ma tanto più esso appariva separato dal cuore della città, tanto più ne costituiva una sua anima profonda: non a caso essere romani è sinonimo di essere “trasteverini”. Questa territorio oscuro, di cui ci parla Ilardi, è diventato col tempo, con il procedere della modernità, un luogo del folklore, uno spazio occupato da turisti, benestanti chic, attori, intellettuali. Ma la storia di questa trasformazione non è stata indolore. Ilardi ci racconta delle “sparizioni” avvenute: di mestieri, di figure, di relazioni, di tradizioni, di dialetti letteralmente cancellati da quello che potremo, in una parola, chiamare progresso.
Il saggio di Enzo Scandurra, infine, apre il libro. In esso si tenta di spiegare come il territorio assuma sempre più una dimensione fondamentale per uscire dalla crisi e per ristabilire rapporti produttivi ed ecologici compatibili con un diverso sviluppo.
Gli autori del libro sono: Cellamare C., De Angelis R., Ilardi M., Scandurra E., Recinti urbani. Roma e i luoghi dell’abitare, manifestolibri, Roma, 2014]
Note
[1] AA.VV., Questo terribile intricato mondo. Racconti politici, Torino, Einaudi, 2008. Si tratta di un libro che ha per oggetto la politica dove questa, però, viene affrontata attraverso racconti inediti di letteratura. Gli autori sono: Affinati, Asor Rosa, Bartezzaghi, Celestini, De Silva, Di Stefano, Fois, Loy, Murgia, Pascale, Siti, Vassalli.
[2] E. De Martino, Il mondo magico, Torino, Boringhieri, 1967; La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali, Torino, Einaudi, 2002
[3] Si veda E. De Martino, Angoscia territoriale e riscatto culturale nel mito Achilpa delle origini, in Il mondo magico, op. cit.
[4] Un pastore in cui De Martino s’imbatte durante un viaggio calabrese in auto, al quale chiede la strada giusta, la direzione valida, viene invitato a salire in macchina per condurre i passeggeri alla meta desiderata. Salì con qualche diffidenza e appena allontanatisi e perduta «la vista familiare del campanile di Marcellinara, punto di riferimento del suo minuscolo spazio esistenziale», la diffidenza del pastore si tramutò in vera propria angoscia. Decisero di riportarlo indietro. Sulla via del ritorno il pastore stava sempre con la testa fuori dal finestrino, alla ricerca del suo punto di riferimento: appena lo rivide apparire in tutta la sua domesticità si rasserenò avendo ritrovato la patria perduta. «Ciò significa che la presenza entra in rischio quando tocca i confini della sua patria esistenziale, quando non vede più il “campanile di Marcellinara”, quando perde l’orizzonte culturalizzato oltre il quale non può andare e dentro il quale consuma i suoi “oltre” operativi: quando cioè si affaccia il nulla. Da La fine del mondo, op.cit.
Tratto da: http://comune-info.net/2014/02/recinti-urbani/


 FORUM ITALIANO DEI MOVIMENTI PER LA TERRA E IL PAESAGGIO
FORUM ITALIANO DEI MOVIMENTI PER LA TERRA E IL PAESAGGIO


